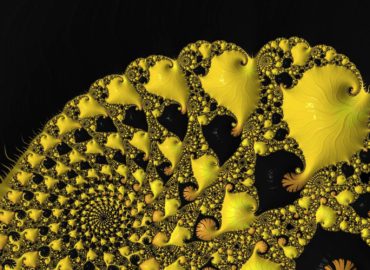Antica accidia – Moderna depressione
L’eterna scontentezza vista con gli occhi dell’arte
Nel mondo serpeggia un filo che ci accomuna tutti ma nel contempo, ci divide: è il disagio di vivere, qualcosa d’indefinito che prima o poi, si presenta senza invito, compare all’improvviso dagli ancestrali meandri dell’inconscio. Pur sentendolo come parte estranea al nostro essere, non riusciamo ad ignorarlo. Percepiamo benissimo che non fa parte di noi, però ci rendiamo conto che proviene da dentro di noi: questo ci spiazza sia individualmente che socialmente perché mina le nostre sicurezze, il nostro rapporto col resto del mondo.
Nell’era contemporanea questo disagio viene definito con vari termini scientifici come disturbo depressivo maggiore, disturbo dell’umore, depressione endogena e così via; molti lo ritengono un male peculiare della nostra epoca.
Ma è proprio così?
In realtà, sin dai tempi più remoti si parlava già di melancolia, un termine obsoleto che ormai, ricorderanno solo gli studiosi di poetica storica. Eppure anche Pindaro ed Euripide narrarono il mito di Bellerofonte il quale, ossessionato dalla brama di diventare immortale, cavalcando l’alato Pègaso, salì in alto nel cielo, pretendendo di arrivare fino al consiglio degli dei.
Ecco il punto nodale: l’umana aspirazione all’immortalità.
Questo è il leitmotiv che accomuna gli uomini di ogni tempo e si ripete come un mantra nei secoli, nei millenni: il desiderio di vivere per sempre, il non potersi accontentare del tempo concesso dalla natura.
È la malinconia di un qualcosa di superiore a cui sentiamo di appartenere. In cuor nostro, siamo consapevoli di esser molto di più, abbiamo insita in noi, la coscienza dell’eternità, percepiamo la sua potenzialità nella nostra entità personale ma nel contempo, questa eternità la sentiamo solo nel suo potenziale, perché nella realtà possibile, ci sfugge. Fa parte di noi ma non ci appartiene, perché il limite che ci inchioda è la materialità, la consunzione, il senso della fine che ci accompagna, silenziosamente, giorno per giorno, anno per anno, durante tutto il nostro percorso esistenziale.
È disumano, sì proprio così, disumano, nascere ed esistere sapendo che un giorno dovremo sparire e non ci basta pensare che quando spariremo non sentiremo più nulla e che semplicemente, non esisteremo più, esattamente nel medesimo modo in cui non esistevamo prima di nascere.
Non basta affatto, perché un conto è il non esser mai esistiti, un altro conto è l’esserci stati e poi dover sparire. La differenza è abissale: non fa parte del nostro DNA accettare disinvoltamente di non esserci più. Possiamo raccontarcela quanto vogliamo ma non è nella nostra natura: non lo è perché se così fosse, lo accetteremmo serenamente, come dato ineluttabile (quale di fatto è, con la differenza che fatichiamo terribilmente, ad accettarlo).
Ecco allora che la nostra intelligenza ci propone una mirabile miriade di palliativi, di scappatoie, illusioni di varia qualità e natura per tentare di sviare, rallentare, ingannare l’inesorabile scorrere del tempo. Non occorre star qui a descrivere gli svariati (a volte risibili) metodi con cui ci arrabattiamo per ottenere l’inutile scopo, credo che più o meno tutti li conosciamo. Meglio occupare lo spazio di questo testo per focalizzare l’attenzione sul fatto che anche l’arte ha sempre affrontato il dilemma del mal di vivere con grande efficacia e genialità.
In effetti non c’ è neppure da stupirsene poiché, sin dai tempi di Plinio, le motivazioni che sempre hanno incalzato l’essere umano a dipingere o a scolpire (oggi anche a fotografare, filmare, usare la digital art, e così via…) rimangono le stesse: fissare un istante, catturare un attimo fuggente da lasciare impresso indelebilmente per l’eternità.
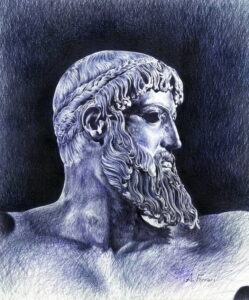 A proposito di Plinio, secondo una leggenda narrata nella sua Naturalis Historia, gli antichi Greci attribuivano la nascita della pittura alla giovane figlia dell’artigiano Butades di Corinto, la quale disegnò sul muro il profilo del suo innamorato, proiettato grazie alla luce di una lanterna, per conservarne l’immagine anche dopo la partenza dell’amato.
A proposito di Plinio, secondo una leggenda narrata nella sua Naturalis Historia, gli antichi Greci attribuivano la nascita della pittura alla giovane figlia dell’artigiano Butades di Corinto, la quale disegnò sul muro il profilo del suo innamorato, proiettato grazie alla luce di una lanterna, per conservarne l’immagine anche dopo la partenza dell’amato.
La Melancholia, a sua volta trae origine dal greco mélanos (nero) e cholé (bile): la nera bile è uno dei quattro umori dalle cui combinazioni dipendono, il carattere e gli stati d’animo delle persone secondo la medicina antica. Dunque umore nero e problemi fisici nell’ antichità, si consideravano abbinati insieme.
Spesso in pittura la tristezza del vivere veniva interpretata come una donna completamente ingioiellata o come un uomo che conta monete. Ma altre volte, era associata (erroneamente, ci permettiamo di commentare) alla Povertà in quanto sinonimo di non-volontà, o peggio ancora, alla Vecchiezza in quanto stanchezza del vivere, uno stato d’animo spesso attribuito a tale condizione umana. Per Dante Alighieri l’accidia in quanto torpore della mente o dell’anima, in quanto disinteresse totale verso il mondo o la vita, verso sé stessi o il prossimo e quindi in quanto disprezzo per il creato o il suo creatore, diventa un peccato degno di punizione. Non a caso gli accidiosi si trovano nel V° cerchio infernale, immersi nel fango che arriva fino alla bocca a simboleggiare l’obnubilazione che li afflisse durante la vita terrena.
Ma è proprio Dante che nelle ime scrive: “Un dì si venne a me Malinconia / e disse: ‘io voglio un poco stare teco”; / e parve a me ch’ella menasse seco / Dolore e Ira per sua compagnia”, a riprova che nella vita chiunque di noi può essere assalito da tristezza, malinconia e nostalgia in qualunque momento.
La lezione che traiamo da questi grandi uomini del passato, a nostro parere è questa: la melancholìa è una condizione inevitabile del vivere; noi dobbiamo adoperarci per di aver il coraggio di combatterla e vincerla in nome dalla Bellezza della vita.
Con l’Umanesimo quattrocentesco in certi ambiti intellettuali si operò un ribaltamento dell’idea peccaminosa dell’accidia trasformandola in una sorta di segno che caratterizzava l’uomo geniale.
Lo possiamo vedere nella celebre incisione di Albrecht Dürer, Melencolia I (1514) in cui la filosofia di Marsilio Ficino e la Scienza dell’anima rinascimentale si riconoscono appieno: la malinconia in Durer è una donna che medita, seduta a terra.
Nota è anche è l’autodescrizione melanconica di Michelangelo: “La mia allegrezz’è maninconia, / e‘l mio riposo son questi disagi” (in Rime 267) rispondente ad un prezioso ritratto che gli fece il pittore Daniele da Volterra, tra il 1548 e il 1553 oggi conservato al Teylers Museum.
 Hieronymus Bosch, però, al contrario continua a raffigurare l’accidia come vizio, nel suo straordinario dipinto I Sette peccati capitali, (1500-1525), oggi conservato al Museo del Prado e molti secoli dopo Otto Dix nel 1933, la ritrae come uno scheletro danzante nel suo omonimo capolavoro.
Hieronymus Bosch, però, al contrario continua a raffigurare l’accidia come vizio, nel suo straordinario dipinto I Sette peccati capitali, (1500-1525), oggi conservato al Museo del Prado e molti secoli dopo Otto Dix nel 1933, la ritrae come uno scheletro danzante nel suo omonimo capolavoro.
Successivamente, il concetto di le Vanitas vanitatis et omnia vanitas (Vanità delle vanità e tutto è vanità) spadroneggiò nell’arte barocca con i fiori caduchi le nature morte in cui il “vanus”, ossia il “vuoto” e la caducità delle cose umane, in pittura esprime la precarietà dell’esistenza e l’inesorabilità del tempo.
Con l’Illuminismo e il posizionamento dell’uomo al centro del mondo si tende a trascurare un po’ il senso della vacuità dell’esistere: le scoperte scientifiche e le nuove idee rivoluzionarie spingono a “nascondere sotto al tappetino” la polvere della tristizia.
Bisogna attendere il Romanticismo crepuscolare e persino Leopardi che torna a parlare di malinconia nello Zibaldone, definendola “quieta e dolce” e “amica della verità”.
All’inizio del Novecento la psicoanalisi di Freud conferisce alla malinconia il significato di lutto inteso come perdita di un qualcosa di enigmatico che non si sa cosa sia.
La metafisica di De Chirico esprime l’enigma, la vastità inconoscibile dell’universo, incomunicabilità e solitudine dell’essere umano: malinconia dell’essere, appunto.
Nel terzo millennio l’odierna psicologia riconosce i rapporti che possono intercorrere tra malinconia e genio creativo. Infatti nel corso della storia molti -davvero molti- artisti o personaggi che hanno segnato la comunità umana, spesso erano dotati di un temperamento malinconico o soffrivano di qualche forma di depressione clinica. Ma l’umore depresso, in realtà, dovrebbe implicare una specie di freno all’energia vitale e al moto dell’attività.
Nell’artista invece, avviene esattamente il contrario.
Dunque la malinconia, la tristezza, la sofferenza ci spingono a creare?
Forse sì, se la reazione umana non è quella di lasciarsi sopraffare ma è quella di trarre profitto dall’ emozione profonda che proviamo quando siamo insofferenti ad un’inconscia carenza di qualcosa di grande che percepiamo sia in noi, sia ‘oltre’ noi, ma che non riusciamo ad afferrare.
Ecco allora che il tutto si trasmuta in creazione di un’opera d’arte.
 Fortunatamente non per tutti gli artisti creatività è sinonimo di malinconia. Henri Matisse, ad esempio, esprimeva la gioia del vivere nel suo famoso dipinto del 1906.
Fortunatamente non per tutti gli artisti creatività è sinonimo di malinconia. Henri Matisse, ad esempio, esprimeva la gioia del vivere nel suo famoso dipinto del 1906.
Matisse è da considerarsi un innovatore nel rappresentare la sua personale ricerca della felicità in un’epoca caratterizzata dall’inquietudine.
Picasso invece raccontava con intensità il tema della malinconia soprattutto nel suo Periodo Blu parigino.
Nel dipinto “Arlecchino pensoso” narra le difficoltà ad integrarsi nell’ambiente francese, per lui che era spagnolo, le vicissitudini economiche che dovette affrontare in quegli anni giovanili.
Nell’era del nuovo millennio, l’era dello “sballo”, dell’eccesso, del vivere senza limiti, quale virtù può far da contraltare per risolverci un po’ di problemi?
Forse la Temperanza?
Un po’ scomoda, poco conosciuta, la più disertata, ma forse anche la più utile per rendere l’essere umano pienamente se stesso, perché modera l’esagerazione ed esercita in noi, l’equilibrio e il dominio degli istinti.
Qualcuno potrebbe domandare: “Ma perché dominare gli istinti se questi ci premettono di esprimere noi stessi al top?”
Potremmo rispondere che lo si dovrebbe fare per assicurarci il dominio sugli istinti peggiori che ledono la libertà degli altri in nome del nostro ego eccessivo, lanciato all’ennesima potenza e trasformato, perciò, in un libertinaggio smodato, riducendo anche noi a diventare dei veri e propri bruti (spesso pericolosi anche per gli altri se ad esempio qualcuno, in preda all’alcool o alla droga, ammazza, guidando, un passante per strada o massacra la propria compagna: accade di frequente oggi, purtroppo; peggio ancora quando accade che, una volta arrestato, se ne esce giulivamente, dicendo: “Non so perché l’ho fatto!”. 
Perché mai l’avrà fatto? Semplicemente, in quel momento si è trasformato in un orrido bruto, succube dei propri eccessi.
Naturalmente con questa affermazione non si vuole certo, competere con i precetti degli studi psicologici o psicoanalitici sulla natura umana, che oggi hanno compiuto molti passi avanti. Per carità, lungi da noi!
Il Nuovo Testamento definisce la temperanza moderazione, sobrietà: “…Vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo” (Tt 2,12)” (CCC n.1809).
Auguriamoci che l’arte continui a sostenerci per riuscire a captare la Bellezza che è in noi e continui a spronarci, per coltivare quel senso d’ Infinito che accorcia le nostre distanze verso la conquista della… Volta Celeste!
Anna Rita Delucca